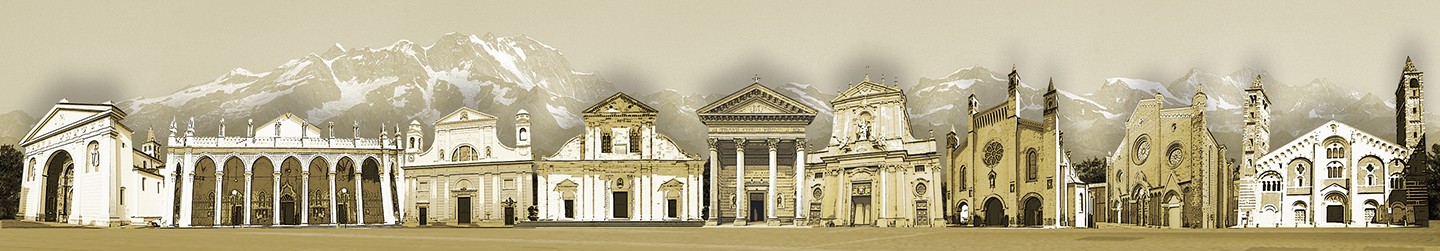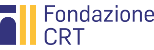Chiese a porte aperte
Chiese a porte aperte
 Share
Share
 Tweet
il mio itinerario
?
Tweet
il mio itinerario
?
Santa Maria di Doblazio
Diocesi di Ivrea ( sec. IX; XVI )
Borgata Doblazio - Promontorio Monte Uliveto 10085 PONT CANAVESE (TO)
Gli storici ritengono che verso il IV secolo fosse presente a Pont Canavese una piccola comunità cristiana che si radunava per la preghiera e per la celebrazione dell'eucaristia in un sacello, ovvero una piccola cella sotterranea, sul Monte Uliveto. Sempre intorno al IV secolo nel luogo dove oggi sorge la pieve, veniva edificata una torre di guardia romana attorno alla quale si insediarono popolazioni che in seguito si convertirono al cristianesimo.
Il controllo del territorio di Pont era ai tempi demandato alla famiglia feudataria dei De Doblazio che, a partire dall’occupazione romana di Eporedia (IV/V secolo), abitavano sotto il Monte Uliveto, in corrispondenza dell’attuale omonima borgata.
L’architetto Camillo Boggio nel suo libro “Le chiese del canavese” del 1887 descrive la pieve di Santa Maria con queste parole: “la pianta...è un parallelogramma con due altari contigui, addossati ad una parete inclinata rispetto ai lati longitudinali, sulla metà dei quali, a regolare distanza verso il centro della chiesa, vi è un’alta e grossa colonna di pietra in un sol pezzo, sostenente due archi di volta. Sopra l’altare di destra un antico dipinto raffigurante la miracolosa apparizione della Vergine al popolo, che essa copre col suo manto. Una cancellata in ferro battuto separa questa parte dal resto della chiesa”.
Un’iscrizione latina, oggi riportata sulla parete a sinistra dell’altare dedicato all’Assunta ed un tempo situata sopra la porta del coro, ricorda una ristrutturazione della chiesa da parte di Arduino, marchese di Ivrea (955 - 1015) e primo re d’Italia, avvenuta intorno all’anno 1000. Gli storici sono propensi ad accogliere l’ipotesi che Arduino, acclamato Re d’Italia nel 1002 a Pavia e costretto a rifugiarsi a Sparone nel 1004 per sostenere l’assedio dell’esercito imperiale di Enrico II di Germania, possa aver provveduto alla pieve di Santa Maria, rifacendo il tetto e donando 100 giornate (partendo dal torrente Soana e fino a Frassinetto) di terreno per il sostentamento del pievano.
Alcune fonti sono del parere che essendo la chiesa di Santa Maria definita “pieve”, la sua originaria fondazione possa risalire addirittura alla fine dell’VIII secolo dopo l’incoronazione di Carlo Magno e la sua promessa al Papa di diffondere il culto della cristiano in mezzo al popolo.
L’antica datazione della pieve di Santa Maria è confermata dalla presenza di sotterranei che hanno la stessa conformazione delle prime chiese romaniche. Tali sotterranei erano usati come cimiteri ma anche come luoghi di culto. L’antichità del sito è inoltre confermata dal campanile circolare, forse costruito sui resti dell’antica torre di guardia dei de Doblazio ed anche da una piccola statua lignea datata inizio 1400.
L’antica datazione della pieve di Santa Maria è confermata dalla presenza di sotterranei che hanno la stessa conformazione delle prime chiese romaniche. Tali sotterranei erano usati come cimiteri ma anche come luoghi di culto. L’antichità del sito è inoltre confermata dal campanile circolare, forse costruito sui resti dell’antica torre di guardia dei de Doblazio ed anche da una piccola statua lignea datata inizio 1400.
Significativa è la presenza di due altari frontali derivanti, forse, dal fatto che la chiesa era una pieve fin dalla sua prima fondazione e, in quanto tale, aveva un altare dedicato ai catecumeni. Altra ipotesi fa derivare i due altari da una primitiva chiesa a due navate rifatta sul finire del XV secolo quando ne divenne possessore, a titolo personale, il monaco benedettino Domenico Manfredi di San Martino che fu anche vescovo della diocesi di Ivrea.
I verbali dei visitatori vescovili, a partire dal 1500, sono le fonti più autorevoli per avere notizie circa la struttura della pieve e documentano le successive modifiche che, nel corso dei secoli, l’hanno rinnovata. Dalle prime visite dei vescovi, sappiamo che Santa Maria era una pieve povera e rozza, a due navate con tetto in legno, poche finestre e con altari in legno o in pietra.
Numerosi sono stati i rimaneggiamenti della struttura originaria che hanno cancellato le tracce dell’antica pieve che dovrebbe trovarsi nei sotterranei. La struttura attuale è costituita da edifici quattrocenteschi come il coro e il presbiterio, secenteschi (la navata) e settecenteschi quali la sacrestia, il campanile e il sagrato.
I due altari centrali, situati nel presbiterio, sono dedicati alla Vergine Maria; sono sovrastati da volte a crociera sostenute da una colonna in pietra locale, in un unico blocco, separato dalla navata da una cancellata in ferro battuto datata 1630.
L’altare di sinistra è stato l’altare maggiore fino alla fine del XVIII secolo ed era inizialmente dedicato a San Giovanni. Quello di destra, attuale altare maggiore, è dedicato alla Madonna delle Grazie ed è sovrastato da un dipinto quattrocentesco che raffigura la Vergine con le braccia spalancate a proteggere il suo popolo costituito da religiosi e laici sia nobili che popolani, nella classica iconografia della Madonna della Misericordia.
La navata centrale presenta tre altari su ogni lato: a sinistra quello di San Rocco, con la statua in pietra datata 1630 e raffigurante il santo. La statua pare sia stata offerta per chiedere protezione contro la peste dagli abitanti della borgata Faiallo che ne vantano il patrocinio.
Il secondo altare è quello di Santa Lucia, in precedenza era dedicato a San Martino. L’altare ha fattura settecentesca e il dipinto raffigura la santa siracusana tra sant’Apollonia e San Martino, venerata dalle operaie della Manifattura di Pont.
Il terzo altare, secentesco, apparteneva alla facoltosa famiglia dei Bogino ed è dedicato alla Madonna di Loreto che campeggia al centro della tela settecentesca, con ai suoi piedi Sant’Antonio Abate, Sant’Agata e San Gerolamo.
Sul lato destro troviamo l’altare della Madonna del Carmelo, citato nel verbale di visita pastorale del 1647e ricostruito nei primi anni dell’Ottocento a cura della Confraternita del Carmelo. La pala presenta la Vergine con il Bambino mentre porge lo scapolare, il segno distintivo della confraternita, a San Simone Stock e ad un altro santo carmelitano.
Il successivo altare, di appartenenza della Confraternita dei disciplinanti, il cui statuto fu approvato nel 1571, è dedicato a San Giovanni Decollato. L’altare fu eretto dalla confraternita nella seconda metà del Settecento e presenta una pala che raffigura al centro la decapitazione del Battista e ai lati San Giovanni Nepomuceno e San Francesco di Sales. L’altare venne eretto in sostituzione di uno precedente, detto della Pietà, che godeva del patrocinio di una nobile famiglia pontese; la tradizione racconta che la tela del precedente altare, raffigurante una croce e la Vergine con il Cristo morto fra le braccia, sia quella che si può ammirare nella cappella dell’Addolorata dell’Orco situata nell’oltre Orco, di proprietà della famiglia Oddono che l’avrebbe acquistata dagli antichi proprietari o ricevuta in eredità da matrimonio.
La famiglia Roscio era la proprietaria dell’altare dei Santi Giuseppe e Anna raffigurati con Gioacchino e la Vergine in una tela conservata nel coro della Chiesa.
L’attuale coro venne rifatto agli inizi dell’Ottocento e arricchito di una tela della fine del 1700 che rappresenta San Giuseppe morente con accanto la Vergine e Gesù.
Davanti agli altari laterali si possono vedere ancora le botole che permettevano la sepoltura dei defunti delle famiglie o delle confraternite, a cui gli altari stessi appartenevano. A porre fine alla consuetudine di seppellire i morti nelle chiese fu l’editto di Saint Cloud del 1804, attraverso cui Napoleone Bonaparte vietava sepolture nelle chiese ed all’interno del perimetro delle città e dei paesi.
Il decreto di Saint Cloud venne recepito nel Regno d’Italia nel 1806 e ne fu diretta conseguenza la predisposizione del cimitero di Santa Maria (1830) e di quello di Peramara (1850) che andarono a sostituire i sepolcreti interni alle chiese ed i precedenti cimiteri in terra.
Nel coro, situato fra il presbiterio e la sagrestia nuova, sono conservati gli scranni utilizzati dai membri delle confraternite e dai cantori che accompagnavano le funzioni religiose con i canti gregoriani. Su un bel leggio è esposto un antifonario della prima metà del Settecento.
La sacrestia nuova, costruita nel 1728, ha le pareti rivestite con pannelli in noce e un ricco arredo costituito da un armadio con sportelli, sedili ed inginocchiatoi.
vita della Vergine.
In una nicchia della sacrestia si trova anche un’urna in marmo, forse trecentesca, con scolpiti i simboli araldici dei Valperga, dei Savoia e i nodi dell’Ordine della Santissima Annunziata. La tradizione la indica come dono del Conte Amedeo di Savoia, detto conte rosso, dopo le guerre del tuchinaggio.
Interessante è invece la lapide marmorea che sovrasta il portone della Chiesa di cui si conoscono autore e provenienza, nonché la data d’esecuzione: Casella Carona, paese sul lago di Lugano, 1631. La scultura rappresenta i simboli della Passione di Cristo inseriti in un blasone araldico in cui campeggia una croce sormontata da un elmo e sostenuto da due unicorni. La scultura fu probabilmente voluta dalla Congregazione di San Giovanni Decollato.
Sotto la volta centrale del porticato brilla una lampada votiva in ferro battuto: le madri di Pont che videro partire i loro figli per la Prima guerra mondiale la offrirono a Santa Maria per invocare la protezione. La tradizione la vorrebbe fusa con oggetti di ferro di uso quotidiano raccolti dalla popolazione piuttosto povera, a significare l’enorme religiosità e devozione del territorio e il profondo amore per la pieve di Santa Maria.
Il trasferimento della parrocchia a San Costanzo e la riduzione dei Sacerdoti hanno modificato la struttura interna della casa parrocchiale e il suo utilizzo. La struttura, che aveva ospitato i Pievani e i vari vicari, nonché un sacrestano e la sua famiglia, fu anche, quando l’istruzione era ancora affidata ai sacerdoti, sede della scuola frequentata dai bambini delle borgate disseminate intorno alla pieve. L’aula era situata sopra il portico di collegamento fra la Chiesa e la casa parrocchiale e vi si accedeva da una ripida scala in legno ancora visibile. Successivamente, per opera della congregazione di carità Opera Pia Moro, la scuola venne spostata in località Pianseretto dove rimase attiva fino al 1980.
Interessante testimonianza del passato è il camminamento con l’acciottolato che conduce all’ossario, forse ciò che resta della “Stra d’la Messa” che saliva da Doblazio, via Sangiapiana o arrivava da Piangiacolin.
Due campanili svettano ancora fieri sui tetti della pieve. Il più antico, quello rotondo, anteriore all’anno 1000, sorge vicino alla pieve, inglobato dalla casa parrocchiale ed è, forse, costruito sui resti della torre di guardia romana. Al suo interno è percorso da una scala a chiocciola, parte in pietra e parte in legno, che sale fino alla cella campanaria. Sulla massiccia struttura svetta una cuspide piramidale in cemento di recente costruzione.
Sopra i tetti della sacrestia si erge il campanile di San Giovanni fatto erigere dalla confraternita che porta il nome del santo allo scopo di suonare il trapasso dei defunti e di scandire i tempi delle funzioni religiose (1750).
Santa Maria presenta, come molte chiese coeve, un pronao, ovvero un porticato, sostenuto da due gruppi di colonnine in pietra e sormontato da un timpano sul quale svetta una pregevole croce di ferro.
La piazzetta antistante la pieve, con il basso muretto e i sedili in pietra, è stata costruita nel 1740 contemporaneamente ad altri interventi strutturali eseguiti sull’edificio. La tradizione racconta che i muretti permettevano ai fedeli di riposarsi dopo le lunghe processioni e di consumare uno spuntino a base di uova sode e marsala prima di tornare a casa.
L’ossario e il cimitero di Santa Maria di Doblazio
Il primo cimitero di Santa Maria, non più esistente, occupava il terreno sul retro dell’edificio; una prima parte venne eliminata per costruire la sacrestia, la seconda era posta oltre un muro e sul finire del secolo scorso le ossa che qui giacevano furono raccolte e deposte nell’ossario.
Quando Napoleone, con l’editto di Saint Cloud del 1804, pose il divieto di seppellire dentro le chiese, si cominciarono a costruire nuovi cimiteri. Malgrado l’editto si continuò per lungo tempo a seppellire nelle chiese e solo nel 1834, come registrato nei documenti d’archivio, venne deliberata la costruzione di un nuovo cimitero presso Santa Maria, ancora visibile sulla strada per Sangiapiana, sul lato nord del Monte Uliveto. Il cimitero entrò in funzione lo stesso anno e da quello successivo ebbe un “becchino” a carico del Comune ma alle dipendenze del Pievano.
Nel 1929, quando si inaugurò l’attuale cimitero di Pont Canavese, si pianificò anche lo smantellamento di quello di Santa Maria di Doblazio. Agli abitanti delle località oltre il torrente Soana venne chiesto di portare i defunti nel nuovo cimitero e per vincere ogni resistenza fu emanata un’ordinanza che vietava tassativamente l’uso del cimitero di Santa Maria e invitava i familiari dei defunti a far trasportare le ossa dei loro cari negli ossari del cimitero di nuova costruzione. Malgrado l’ordinanza in molti preferirono soprassedere e lo smantellamento dell’antico cimitero non avvenne tanto che nel 2019 è stato deliberato un intervento di ristrutturazione e bonifica e, contestualmente, è stata creata un’area per la disposizione delle ceneri. Un pezzo di storia che finalmente è tornata a vivere.
Nel 1980 fu sistemato l’ossario, per dare una degna collocazione all’enorme quantità di ossa rinvenute durante lo smantellamento del cimitero più antico. Durante gli scavi per interventi di consolidamento delle fondamenta della pieve sono stati altresì individuati numerosi cunicoli che si dipartono dal locale destinato ad ossario e si diramano in molte direzioni sotto la chiesa; questi cunicoli sono tuttora chiusi perché non illuminati e perchè hanno pavimenti sconnessi da dove affiorano ossa e materiali di sepoltura.
Dedicata alla B.V:M: assunta ....
Dans les environs
Liens externes
Accessibilité
Le site pourra être visité durant l'horaire indiqué sauf en cas de célébrations liturgiques
| Lun-Dom | - |
|---|
Infos
- cathédrale
- Cattedrale di Ivrea
- diocèses
- Ivrea
- type d'édifices
- Pievi
- adresse
- Borgata Doblazio - Promontorio Monte Uliveto 10085 PONT CANAVESE (TO)
Services
- accessibilité

- accueil

- didactique

- accompagnement

- bookshop
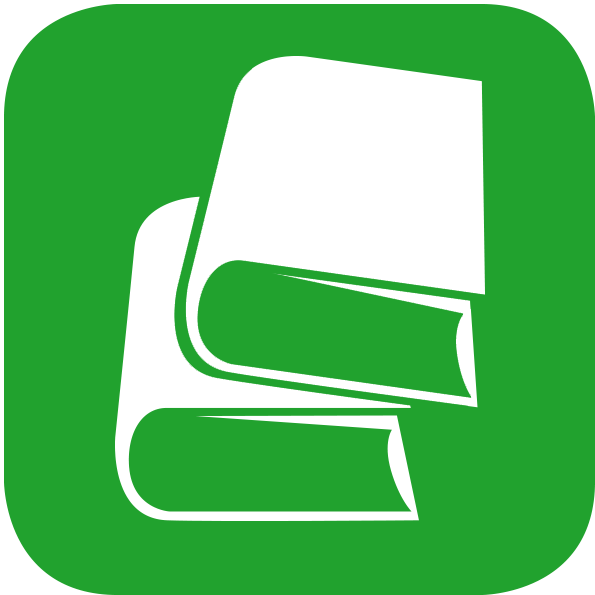
- restauration

OÙ DORMIR À PROXIMITÉ
OSTELLO IVREA CANOA CLUB
VIA DORA BALTEA 1/D, IVREA, 10015, TO
OSTELLO
3280999579 info@ostelloivrea.it
B&B Verde Musica
Via Cavour 10, Borgofranco d’Ivrea, 10013, TO
Bed & Breakfast
3490835837 bbverdemusica@gmail.com
OSTELLO SAINT MARTIN
VIA SCHIGLIATTA 1, PONT-SAINT-MARTIN, 11026, AO
OSTELLO
0125804433 / 3472232039 info@comune.pontsaintmartin.ao.it